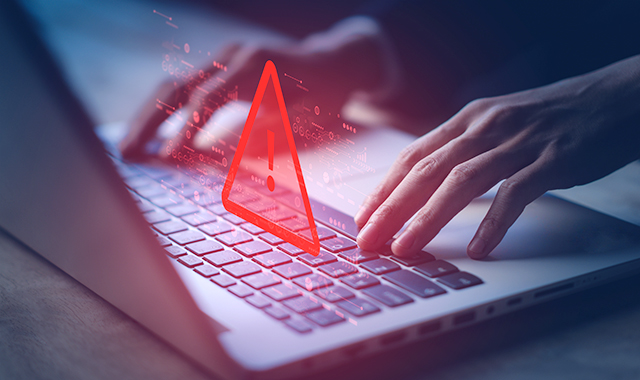Se c’è un giorno in cui abbiamo avuto la sensazione di essere precipitati indietro nel tempo, forse è il 9 marzo scorso, quando le immagini delle città hanno cominciato a spogliarsi della presenza umana. Quelle foto vuote davano l’idea di una paura strana, antica, dove il silenzio non scorreva, ma si accumulava, il silenzio dell’ansia e della colpa, e di tutte quelle cose che spariscono alla nostra vista. Con il coronavirus siamo tornati a un tempo lontano funestato da epidemie terribili, peste, vaiolo, tifo e colera, senza le certezze di una società invincibile, capace di essere reale e virtuale insieme. Pensavamo che non esistessero più nella nostra concezione della vita, e che la quarantena fosse solo una parola del passato. E invece, ci siamo ritrovati a vivere, anche nel mondo del web, come succedeva quando non c’erano computer, cellulari, macchine, aerei, con la stessa identica paura, perché la morte è l’unica cosa della vita che è rimasta uguale e anche la sua paura non può essere diversa. Per contenere i contagi, racconta uno studio della Fondazione ProPosta (in particolare, condotto da Paolo Marcarelli e Riccardo Marzola), in quei secoli lontani “i viaggiatori e le merci, inclusa la corrispondenza, venivano inviati nei lazzaretti, dove in appositi locali si effettuava anche la disinfestazione della posta”, una pratica di cui si fa cenno già nel 1493 a Venezia. Chi arrivava da luoghi pericolosi, veniva isolato, come è successo adesso agli italiani in Spagna o in Austria.
Cosa succedeva alle lettere
La quarantena si protraeva anche dopo che l’epidemia si pensava fosse stata sconfitta. Nel 1631, a Pisa, un editto minacciava tutte le donne e i ragazzi che, “finita la quarantena, non si ardischino né presumino uscire di loro casa liberamente, ma solo con licenza de’ signori capi strada, e quella ottenuta non possino andare vagando e oltrepassare il ponte né andare a messa in altra chiesa”. Molto prima di questo editto, intorno al 1400, la carta era stata indicata come uno dei mezzi attraverso i quali la peste poteva diffondersi. Gli Stati italiani furono i primi a disinfettare la corrispondenza, con modalità che variavano a seconda delle zone. A Venezia nel 1493 si stabilì di “raccogliere tutte le lettere che provenivano da luoghi infetti o sospetti e aprirle e profumarle”. A Bologna, per la peste del 1630, si diede ordine di aprire le “valige, levando fuori le lettere, e si faccino prima passare per aceto, poi asciugare nel forno, e asciugate che sono, le porranno ne fagotto a profumarle”. Il metodo più in uso però era quello di disinfettare la posta con il fuoco. Le lettere venivano afferrate con lunghe pinze di ferro, messe in una gabbia rotante e sottoposte all’azione di fumi sulfurei. Potevano essere affumicate esternamente e allora si metteva uno di quei timbri conservati nell’Archivio delle Poste presso il Museo storico della Comunicazione con la scritta “Netta fuori sporca dentro”. Oppure si facevano anche dei tagli sulla lettera per far passare i fumi o i vapori all’interno, o la si apriva passandola poi vicino alla fiamma, e in questi due casi la dicitura stampata sulla busta recitava “Netta fuori, netta dentro”. Si utilizzavano appositi forni nei quali il fuoco era alimentato da semplici sterpaglie, ma più frequentemente con legni odorosi e sostanze aromatiche.
Gli uffici sanitari e le prime mascherine
Durante il colera del 1873, per cui furono imposte severe misure sanitarie per tutte le navi anche provenienti dall’estero, Venezia e Genova finirono isolate con la paralisi del commercio. Un documento dell’epoca sottolinea che “si posero in opera tutti gli sforzi diretti a ridurre i danni e a tenere vive nel miglior modo possibile le comunicazioni postali”. La quarantena e il blocco delle navi erano da sempre le misure più diffuse. L’origine della quarantena sarebbe dovuta a un fatto accaduto nel 1347 quando ai passeggeri di un vascello attraccato a Dubrovnik in Croazia fu imposto di attendere per un periodo di 30 giorni poi esteso a 40 prima di poter scendere sulla terraferma in modo che non si diffondesse la peste. Alla fine dell’800 invece cessarono le misure per disinfettare le lettere: nel 1886, grazie agli studi di Filippo Pacini e di Robert Koch, venne studiato e isolato il batterio che isolava il colera e soltanto allora ci si rese conto che tutti gli sforzi fatti fino a quel momento erano inutili, perché le lettere non potevano trasmettere la peste né il colera. Da allora, il servizio postale è diventato ancora più importante nei giorni difficili di un’epidemia. Per il colera del 1910 “aumentò considerevolmente la corrispondenza perché vennero emessi dalla Direzione Generale della Sanità, dai Comitati della Croce Rossa e dagli uffici sanitari numerosissimi telegrammi per le necessarie misure profilattiche”, come attestato da un documento dell’Archivio delle Poste: più un milione e 160.913 rispetto all’esercizio precedente. Ma molte cose sono rimaste uguali nel tempo nelle epidemie. Come le mascherine protettive, che venivano usate già dagli addetti della disinfezione della posta presso Trieste all'inizio dell’800: “Le persone che si occupano delle operazioni preparatorie per la disinfezione devono a propria tutela servirsi di un apparato respiratorio di cotone, il quale viene legato e si applica al naso e alla bocca. Prima e dopo la manipolazione postale queste persone si lavano le mani e le braccia e si disinfettano anche i vestiti usati durante tale operazione”.
Leggi qui tutte le notizie dello speciale “160 anni di Poste Italiane”